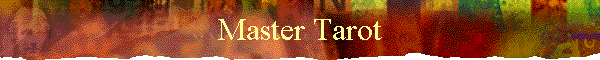|

|
Master
Tarot: la struttura
di
Dario Distefano
Terza
Parte |
Dopo
aver cacciato i mercanti dal tempio cosa succede e cosa resta da fare?
Le
prossime quattro carte ci mostrano un percorso fatto di semplicità ma
difficile e doloroso contemporaneamente.
Dalla
carta n. XIII, la Cena, alla n. XV, il Bacio, viene raffigurato i Maestro
che avevamo visto solo nella carta n. I, il Figlio dell’Uomo. È
l’archetipo di ogni singola vita individuale che sta percorrendo questo
cammino lungo la Via.
La
Cena (n. XIII)
Il
volto del Maestro, la barba e i capelli lunghi, nelle mani tiene una tazza
di vino, davanti a lui c’è il pane.
Tutto
è di una semplicità estrema e proprio per questo così difficile da
sostenere. Il Maestro e i suoi discepoli stanno consumando insieme la
Cena. Quello che facciamo tutti noi quotidianamente, chi da solo, chi in
compagnia; ma quanta attenzione portiamo a queste azioni così quotidiane
e semplici. Diamo tutto per scontato: mentre ceniamo pensiamo ad altro,
parliamo, leggiamo, guardiamo la tv.
Non
siamo presenti, eppure “questo è il mio corpo, questo è il mio
sangue”. Al di là di tutte le dispute teologiche o religiose, ancora
una volta una verità semplicissima: il nostro corpo e il nostro sangue
esistono perché mangiamo il cibo e condividere con gli altri il cibo e il
vino è, veramente, condividere il corpo, il sangue, noi stessi.
Non
posso fare a meno di pensare a quante volte, in una tradizione così
lontana dalla nostra, i maestri zen ripetono che il loro miracolo è
“mangiare quando ho fame, dormire quando ho sonno”.
Oppure
bere una tazza di tè come essenza dello zen. Portare l’attenzione su
gesti così quotidiani significa veramente essere presenti a questo
momento.
Anche
in questa occasione, poi, mi sembra che ci sia una santificazione del
corpo e della materia. Il pane, il vino, le mani, la vite e i tralci:
dov’è scritto che il nostro corpo e la vita su questa terra siano
qualcosa da evitare, rinnegare o mortificare?
Amatevi
l’un l’altro (n. XIV)
Il
Maestro lava i piedi ai discepoli: un grande atto di umiltà, di
purificazione e di amore.
Come
prima il Maestro ha accettato l’offerta di essere unto e profumato,
anche da parte di donne ritenute pubbliche peccatrici, ora dimostra che si
può e si deve ricambiare questa offerta.
Siamo
tutti bisognosi di amore, aiuto, servizio e, nello stesso tempo, siamo
tutti in grado, chi più chi meno, di dare aiuto, servizio, amore.
A
me sembra questa una grande lezione sull’amore non egoistico,
sull’amore quindi, e sulla necessità e capacità di essere al servizio
delle circostanze.
“Sapere
come accantonare le esigenze personali per assecondare le necessità
imposte dal momento è un’arte preziosa.” (Deng
Ming Dao, Tao per un anno, p. 147).
Questo
prendersi cura parte proprio dai piedi, da quella parte del nostro corpo
che riteniamo più umile, quasi da nascondere e da non nominare. I piedi
che ci sorreggono, che ci permettono di camminare, che ci radicano sulla
terra: da dove volete cominciare, altrimenti?
Prendersi
cura dell’altro diventa un atto terapeutico per entrambi, come scrive
Brazier in “Terapia Zen”: “Le piante hanno bisogno di essere
innaffiate. Una stanza ha bisogno di essere pulita. I vestiti hanno
bisogno di essere rammendati. Questi sono tutti atti di compassione, anche
se il “destinatario” non è necessariamente un essere animato... La
gente fa per compassione delle cose che non farebbe per se stessa” (p.
184/185) e più avanti “L’incapacità di avere compassione e la
radice delle forme più acute di sofferenza mentale. La compassione è
l’antidoto all’odio e alla repulsione.” (p.
187)
Guardiamoci
attorno, ancora una volta portiamo l’attenzione a quello che ci
circonda: se ad un bimbo piccolo cola il naso, non prendiamo il fazzoletto
e lo puliamo?
Siamo
tutti sperduti come bimbi piccoli e a tutti, a turno, ci cola il naso.
Il
Bacio (n. XV)
Lo
sfondo della carta è molto scuro con delle pennellate di rosso, così
come è rossa una parte della cornice esterna della carta.
Vediamo
il volto del Maestro che riceve il bacio da parte di un giovane che ci da
le spalle. Anche sulla veste bianca del Maestro ci sono tratti di rosso.
Da
chi possiamo essere traditi o chi possiamo tradire noi stessi?
Solo
chi ci è vicino, solo chi ci è caro, può tradirci o essere tradito da
noi. Il nostro mito comincia con il primo tradimento di Eva e del serpente
e via via si snoda attraverso altri tradimenti.
Quali
sono stati i primi tradimenti della nostra vita? Quando mamma e papà ci
hanno fatto qualcosa che abbiamo vissuto come un tradimento del nostro
amore e del nostro bisogno di sicurezza e fiducia.
O
quando siamo stati noi a tradire la loro fiducia e le loro aspettative per
affermare la nostra individualità e il nostro essere noi stessi.
Parlando
della disposizione per quattro delle Carte Maggiori, ho già citato il
saggio di J. Hillman sul tradimento e altre riflessioni interessanti sono
state elaborate da Carotenuto in “Eros e Pathos” e “Amare
Tradire”.
Vorrei
riportare questo passo da Eros e Pathos: “Pensiamo alla figura
tragica di Giuda. Al di là della “lettera” dei Vangeli, tutti gli
scrittori che si sono successivamente misurati con questo personaggio non
hanno mai dubitato del suo amore per Gesù. Per quanto il suo nome sia
diventato ben presto sinonimo di traditore, al “bacio di Giuda” non si
può non dare un significato ambivalente... Io personalmente sono convinto
che nel fenomeno del tradimento c’è sempre una complicità; tradito e
traditore, oltre che corresponsabili, sono anche complici in quello che
accade”. (p. 94)
E
più avanti: “L’esperienza del tradimento, tradotto in termini
psicologici, ci rimanda a uno dei processi fondamentali della nostra vita
psichica, e cioè a quella che chiamiamo “integrazione della propria
ambivalenza”. Vorrei anche sottolineare il fatto che questa particolare
esperienza non riguarda soltanto il portatore dell’aspetto peggiore, e
cioè chi inganna, ma anche il tradito, il quale ha inconsapevolmente
messo in moto dei meccanismi tali per cui il partner ha preso sulle spalle
tutto il male, tutta la negatività della situazione”
(ibidem, p, 95)
Infatti
nella Carta che stiamo esaminando le due figure sono unite in questo
abbraccio e questo bacio e non sembra esserci, da parte del Maestro,
nessun tentativo di sottrarsi.
Così
si esprime Jodoroswsky a proposito di Giuda: “Senza Giuda, Gesù
non avrebbe trionfato dato che la sua gloria passa attraverso la
crocifissione. Giuda perciò deve essere venerato: è una bella figura,
dovremmo dedicargli delle chiese... Dobbiamo capire che è stato Gesù a
obbligare Giuda a tradirlo, ad affidargli la sacra missione di tradirlo, e
che Giuda ha obbedito affranto dal dolore”. (p.
376)
Parole
forse difficili da accettare secondo una visone semplicistica dei fatti,
della vita, una visione ingenua in cui il bene è tutto da una parte e il
male tutto dall’altra.
Ma
è proprio così?
L’Urlo
(n. XVI)
Questo
non significa sottovalutare o negare il dolore e la sofferenza. Giuda va
ad impiccarsi, Gesù sulla croce grida: “Dio mio, Dio mio perché mi hai
abbandonato?” E poi, secondo il racconto di Matteo e di Luca, a quel
grido si verifica un vero e proprio terremoto, la terra stessa trama, i
sepolcri si aprono.
Il
processo che è iniziato con la Frusta (n. XII) è un processo che porta
allo scoperto il nostro io, che porta ad uno scontro interiore ed
esteriore. Nel momento in cui cominciamo a fare pulizia nel nostro tempio,
ad abbattere idoli e consuetudini, stiamo lavorando per la morte del
nostro vecchio io e, con esso, di tutti i rapporti e le relazioni che
esistevano con quella vecchia modalità. Allora l’io e i vecchi rapporti
si ribellano e si difendono con tutte le loro forze.
Quando
tradiamo o siamo traditi, consapevolmente o più spesso inconsapevolmente,
stiamo lavorando per uscire da quella situazione di “fiducia
primaria”, di giardino dell’Eden, che è piacevole ma non ci permette
di integrarci, di individuarci o di risvegliarci.
“Infatti
solo nel momento in cui Dio lo abbandona, Gesù diviene veramente umano,
soffre la tragedia dell’uomo... Padre e Figlio non sono più una cosa
sola: questo è un mutamento radicale nel cosmo maschile... dopo che il
fianco di Gesù, tradito e morente, fu squarciato, nel mondo entrò
l’amore” (J. Hillman, op. cit. p. 103)
L’urlo
è anche un non trattenere dentro di sé, un non ripiegare su se stessi.
L’Urlo ci impedisce, e impedisce al mondo, di dimenticare, di rimuovere,
di sotterrare nelle profondità dell’inconscio il proprio dolore e la
propria sofferenza.
L’Urlo,
vorrei dire, ha anche la funzione di essere levatrice verso il nuovo, come
l’urlo di dolore del parto precede la nascita della nuova vita.
L’Urlo
da solo non basta ma tacere o trattenersi non serve.
L’Urlo
esce da tutto noi stessi, in quel momento siamo l’Urlo e questo acquista
un potere quasi magico.
Un
maestro zen stava per morire. I suoi discepoli gli chiedono di lasciare,
come tradizione, una poesia. Il maestro detta tre strofe. Un discepolo
dice: “Maestro manca la quarta”. Il Maestro lancia il suo urlo
trionfante e muore.
L’Urlo
ci ricorda anche che per quanto realizzati possiamo essere, o illuminati,
questo non ci mette al riparo dalla sofferenza e dal dolore.
L’Urlo
ci dice che dobbiamo diventare un tutt’uno con la sofferenza e il dolore
stesso, dobbiamo porre fine alla separazione.
Dario
Distefano
Aprile
2005
La
quarta ed ultima parte di "Master Tarot: la struttura" sarà
pubblicata sul prossimo numero de "Le Ali di Ermes", on line dal
21 aprile 2005.