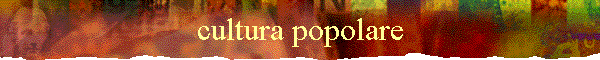Streghe: eretiche o erboriste?
di Giuseppe Nativo
Peccano tutti quelli che credono “…alli sogni et alli incanti, alli
indovini, a stregarie…”, così si esprime in maniera chiara e
perentoria uno dei sinodi diocesani (1553 - Siracusa, sotto la cui
giurisdizione ecclesiastica ricadevano i territori della Contea di Modica)
in cui è disposto la scomunica alle esercenti delle “arti malvage”, alle
indovine ed alle streghe che intrattengono “commercio con li demonij”.
In uno “Spettacolo degl’Inquisiti fatto in Palermo nel 1640” sono
condannate per “magaria” (stregoneria) alcune donne per “haverse
avantato… a certi rimedij che faceano…”.
Una credenza popolare, cantata in filastrocca, proveniente dal territorio
modicano (Guastella, “Le Parità”, pp. 50 – 51), riporta con dovizia di
particolari le operazioni e le caratteristiche più comuni delle
“maliarde”:
“Lu suli cu la luna po’ aggrissari,/ jiri ppi l’aria comu va lu ventu,/
‘mmienzu li porti ciusi trapassari,/ l’uomu cciù forti addivintari lientu,/
l’amici stritti falli cutiddiari,/ mariti e moggi sciarri ogni mumientu;/
uomini e donni po’ fari ciuncari,/ dulura fuorti, e nun aviri abbientu”.
Il Tribunale della Santa Inquisizione siciliana di rito spagnolo pone la
massima attenzione alla delicata problematica, tant’è che la sede
palermitana, nei primi decenni del XVII secolo, dispone la costruzione di
un “edificio per chiudere e murare le magare, le quali fanno morire a loro
volontà chi vogliono per odio o nimicizia…”.
Pozioni per guarire, per alleviare dolori, filtri magici per fare le
“malie” ma anche per “distruggerle” sono le “armi” utilizzate da talune
“femmine”, talvolta “esperte erboriste”, tal’altra “furbastre” che
utilizzano tali espedienti per spillare soldi agli sprovveduti.
Secondo il Guastella, nella Contea di Modica una maliarda cerca di guarire
un povero infermo “affatturato” (cioè colpito da “fattura”, “stregato”)
svolgendo operazioni e segni “particolari” quale esperta nella sua
“professione”! Essa “…congegna una crocina di canna in un corno
dell’arcolaio, prende due foglie di valeriana e le mette sul capezzale;
immerge un pugno di sale entro una brocca d’acqua, e ne sparge le pareti
ed il pavimento”. Le comari presenti, imitando il suo esempio, si
scoprono il seno, si “strecciano” i capelli, si inginocchiano, battono tre
volte i ginocchi recitando apposito scongiuro.
In un’epoca in cui i medici sono troppo rari o costosi per il popolino,
talune donne si rivelano il punto di riferimento per cercare di alleviare
o guarire da alcune malattie, che oggi non vengono quasi neppure
considerate ma che in quel periodo rappresentano un problema o un rischio
reale.
Le streghe svolgono così la loro attività di curatrici, utilizzando, nella
loro quotidiana pratica, oltre i segni e le “preghiere”, anche le
proprietà intrinseche di determinate piante.
Le pratiche farmacologiche delle grandi scuole mediche dell’epoca si
rivolgono perlopiù a problemi di igiene, dietetica e medicina preventiva,
ma quando approdano all'ambito terapeutico si rivelano essenzialmente di
tipo empirico o entrano nel campo del fantastico. A differenza dell'empiria
o della simpatia del rimedio dotto, le erbe delle streghe (studi in
proposito considerano quest’ultime come vere e proprie “erboriste”,
conoscitrici di molti prodotti naturali e delle loro proprietà) cercano di
operare una sorta di "audace omeopatia". Il veleno può diventare un
antidoto, il convulsivo seda il delirio, gli urticanti guariscono le
piaghe e un eccitante può diventare un analgesico.
Giuseppe
Nativo
gennaio 2006