|

 Il "Museo del Fumetto" di S. Croce Camerina ha promosso un interessante Convegno
regionale sul tema "Fumetti e Didattica", che si svolgerà il 1° e 2 dicembre
prossimi. Sull'iniziativa e sul Museo, pubblichiamo di seguito due articoli di
Giuseppe Nativo.
Il "Museo del Fumetto" di S. Croce Camerina ha promosso un interessante Convegno
regionale sul tema "Fumetti e Didattica", che si svolgerà il 1° e 2 dicembre
prossimi. Sull'iniziativa e sul Museo, pubblichiamo di seguito due articoli di
Giuseppe Nativo.
|
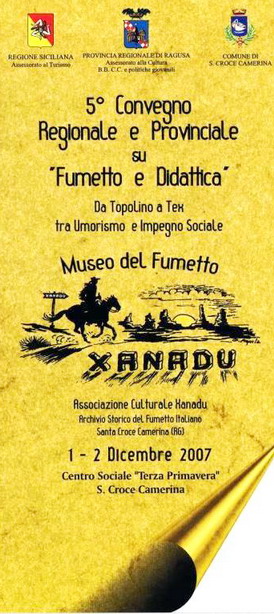
Locandina del Convegno "Fumetto e
Didattica"
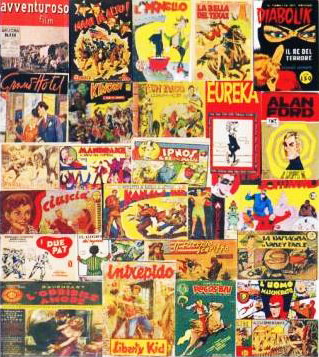
Alcune testate di famosi fumetti

L'architetto Giuseppe Micciche',
fondatore del "Museo del Fumetto" di S.Croce Camerina (RG)
|
Le “nuvole parlanti” si
danno appuntamento a S. Croce Camerina
Fumetti e Didattica
Dal 1° al 2 dicembre importante convegno su “Fumetto e
didattica” promosso ed organizzato dal Museo del Fumetto
di Giuseppe Nativo
“Per tutti i diavoli, che mi siano ancora alle costole?”.
Corre l’anno 1948. Inizia così la lunga carriera, percorsa da continui successi,
del personaggio di Tex che ha fatto vivere “svaghi proibiti” a tantissimi
giovani, oggi cinquantenni. Fino a pochi lustri or sono il fumetto era
considerato una lettura poco “colta”, un passatempo di serie “B” rispetto ai
“classici” della letteratura. I fumetti, oggi, fanno parte del normale “consumo
quotidiano”, alla stessa stregua del cinema e della televisione, acquisendo
pieno titolo per essere inclusi nella cultura moderna come una “componente
predominante della psicologia umana”. A pensarci bene, essi presentano alcune
curiose caratteristiche che possono inquadrarsi nella “storia delle culture”. Il
fumetto inizia come “arte popolare d’avanguardia”. Disegni e parole non soltanto
coesistono, ma si compenetrano. Da un lato la parola che, oltre ad esporre con
dialoghi, pensieri e commenti, è volta a manifestare voci, suoni, rumori e,
soprattutto, si adatta ad essere “disegnata”, dall’altro il disegno che non solo
illustra, ma si adatta facilmente alla sequenzialità delle tavole a fumetti
acquistando un linguaggio vero e proprio: una sorta di “semantica del fumetto”.
Il fumetto, sin dai suoi primi vagiti (il 1896 segna la
data di nascita dell’industria del fumetto con l’apparizione delle prime strips
di Yellow Kid, un ragazzino pelato, orecchie a sventola e con addosso un enorme
camicione, sul supplemento domenicale del quotidiano New York World), si
presenta come una innovazione nella storia della iconografia e della narrativa
con un aspetto che, a linee larghe, potrebbe essere definito “double-face”: da
un lato l’approccio “selvaggio e provocatorio” di Yellow Kid e dall’altro le
raffinatezze pittorico-oniriche di Little Nemo (bambino americano di 5 anni,
nato nel 1905 dalla penna di Winsor McCay, che ogni notte intraprende avventure
sconfinanti nell’impossibile). Negli anni successivi il fumetto si “assesta”
senza presentare ambizioni avanguardistiche. Nascono e imperversano personaggi
come Superman o l’Uomo Mascherato, Mandrake o Mickey Mouse che, indubbiamente,
affascinano intere generazioni di ragazzi. Oggi si ravvisa una terza fase
caratterizzata da un fumetto che è sospinto di nuovo sulla via dell’avanguardia.
Il primo passo si è compiuto qualche decennio addietro quando dalla carta
stampata, rappresentata dal fumetto inteso in modo classico, si passa ad una
nuova metodologia di fare fumetto sfruttando lo sviluppo dei nuovi media: la
televisione, che introduce l’animazione dei personaggi. Con l’avvento
dell’animazione si rileva la necessità di apportare delle caratteristiche nuove
e coinvolgenti rispetto alla forma originaria del fumetto. L’animazione
tridimensionale, le nuove musiche e le sonorità sostituiscono l’apparizione
sistematica del suono onomatopeico figurato giustificando il passaggio al nuovo
media. L’attuale sviluppo tecnologico ha creato nuovi media e nuovi strumenti di
comunicazione con caratteristiche innovative. Uno di questi nuovi settori di
sviluppo della comunicazione è Internet. Inizia un altro tipo di esperienza: il
fumetto viene pubblicato in rete. Nel caso del Web la prima caratteristica che
viene sfruttata è l’interattività che non si riscontra nel comic book (fascicolo
contenente, in genere, un episodio completo di un personaggio; il corrispondente
– ma non del tutto equivalente – termine italiano è quello di albo) né nel mezzo
televisivo. E’ ciò che sta accadendo presso l’americana Marvel, editrice dei
famosi Supereroi come l’Uomo Ragno, i Fantastici Quattro, Capitan America, Devil,
Thor e molti altri. La Marvel ha immesso nel suo web-site migliaia di storie dei
suoi eroi. Da un punto di vista della ferrea e crudele logica di mercato ciò
comporterà sicuramente una riduzione nelle vendite dei fumetti in forma cartacea
con notevoli problematiche che appesantiranno l’approccio economico dei punti
vendita. Tuttavia la rete offre uno spazio virtualmente illimitato per le
pubblicazioni amatoriali che nel web potrebbero ritagliarsi una giusta
visibilità non facilmente ottenibile nell’editoria tradizionale. Inoltre
attraverso i link (in una struttura ipertestuale, collegamento che associa a un
elemento di informazione un’altra informazione ad esso correlata) si possono
creare circuiti tematici non vincolati da problematiche di carattere economico o
editoriale (problematiche presenti nei supporti cartacei), mentre l’interazione
diretta e immediata con i lettori (ad esempio attraverso forum, chat e
mailing-list) potrebbe rendere le risorse a cui accedere ancora più estese.
Risulta, dunque, evidente che inserendo il fumetto in tale nuovo contesto cambia
il rapporto che intercorre con il lettore, che da fruitore diventa attore.
All’interno della rete il lettore, o meglio l’internauta, non sarà legato ad un
rigido schema discorsivo, ma potrà sfogliare le proprie pagine, scrivere i
propri percorsi nonché scegliere dove andare.
Al di là della valenza comunicativa e/o interattiva, il
fumetto possiede certamente una sua valenza didattica in quanto riesce a
veicolare messaggi di alto contento storico-sociale o essere considerato nel suo
valore artistico. Il fumetto fa parte di quella “letteratura disegnata” intesa
come strumento culturale in cui vanno a confluire obiettivi didattici, quali il
recupero di conoscenze storico-grafiche e, non ultimo, lo studio di tendenze,
pensiero ed evoluzioni di una memoria stratificata nel tempo che può essere
letta attraverso le avvincenti storie dei fumetti. Insomma una problematica
tutta da affrontare con gli operatori culturali.
“Il futuro del fumetto” e “Fumetto e didattica” sono i
temi che saranno trattati nel corso del 5° Convegno sul fumetto che si terrà l’1
e 2 dicembre a Santa Croce Camerina (Rg). A proporli, attraverso illustri
relatori (F. Spataro, docente di Scienze della Comunicazione all’Università di
Catania; L. Corteggi, art-director della Editrice Bonelli e da decenni
apprezzato protagonista nel campo del fumetto) è l’Associazione Culturale Xanadu
che gestisce il “Museo del Fumetto” (www.museodelfumetto.net),
una realtà unica in Sicilia, che ospita diverse migliaia di “pezzi” storici tra
albi, giornalini e periodici per un arco temporale che va dai primi anni del
Novecento sino ai giorni nostri.
Giuseppe Nativo
Novembre 2007 |
|



|
Importante anniversario per il "Museo del
Fumetto" di Santa Croce Camerina
Sette anni fra le nuvole parlanti*
di Giuseppe Nativo
“I fumetti hanno
sempre la vocazione di narrare gli attimi privilegiati di personaggi immaginari
destinati a vivere un eterno presente. La struttura della narrazione si fonda su
un’armonica sutura di suoni e di immagini”. Questo scriveva Oreste Del Buono sul
mitico “Europeo” oltre trent’anni fa per dire che il fumetto fa parte di quella
“letteratura disegnata” intesa come veicolo culturale in cui vanno a confluire
obiettivi didattici, quali il recupero di conoscenze storico-grafiche e, non
ultimo, lo studio di tendenze, pensiero ed evoluzioni di una memoria
stratificata nel tempo che può essere letta attraverso le avvincenti storie dei
fumetti.
Sulla base di tali considerazione nasce, nel 2000, a
Santa Croce Camerina, in provincia di Ragusa, il “Museo del Fumetto Xanadu”
fondato dall’architetto Giuseppe Micciche'. Impegnato da diversi anni nella
raccolta, selezione e conservazione dei variegati esemplari di fumetti, l’arch.
Micciche' è riuscito ad implementare l’archivio storico del Museo arricchendolo
di materiale (raccolte e collezioni) reperito da ogni parte d’Italia. La
struttura museale, presente anche su rete internet, unica nel suo genere in
Sicilia ed una delle pochissime in Italia, con i suoi 150 mq di esposizione
permanente, presenta al suo interno – in modo ampio ed esaustivo – un percorso
storico del fumetto che abbraccia un intervallo di tempo che va dagli inizi sino
ai giorni nostri.
Attraverso le varie sale si può avere una
visualizzazione del materiale cartaceo che, suddiviso in base alle diverse case
editrici, parte dal periodo anteguerra con case editrici simbolo (Nerbini,
Mondadori, Universo, Vecchi) ed altre, dalla vita commerciale abbastanza breve,
che hanno dato vita a personaggi e testate quali (per citarne alcune) Topolino,
L’Avventuroso, Intrepido, Il Vittorioso, Il Corriere dei Piccoli. Nel
dopoguerra, sebbene le difficoltà del periodo, sorgono altre case editrici tra
cui l’Editrice Audace (divenuta in seguito “Bonelli”), la Victory, la Ventura e
relativi personaggi o testate quali: Tex, Miky, Blek, Tarzan, Monello, Albo
dell’Intrepido e tanti altri. Per la gioventù dei primi anni del dopoguerra i
giornalini sono una forma di “cultura alternativa” al di fuori di quella
scolastica. Talora i genitori, supportati dalla cultura dell’epoca,
costituiscono un forte ostacolo per una “serena” lettura dei fumetti che, non di
rado, vanno al macero. E’ una lotta senza quartiere ma perdente, come dimostra
l’enorme quantità di esemplari sopravvissuti. In questa lotta si inseriscono le
case editrici riducendo il formato degli albi ed introducendo così il formato
striscia, avuto riguardo anche alla scarsità della carta che favorisce tale
processo.
Le caratteristiche didascalie in calce a ciascuna
vignetta vengono sostituite dalle “nuvolette”, simili a sbuffi di fumo,
utilizzate per riportare il dialogo tra i personaggi. A seconda del tratto che
ne definisce i contorni, la nuvoletta può esprimere un discorso parlato o
pensato, o ira, o paura. Spesso sono utilizzati segni con chiare funzioni
onomatopeiche (Gulp!, Sigh, Sob, Boom!). Dalle “mini” storie, molto
schematizzate degli anni ’30 e ’40 si passa a quelle più articolate dei decenni
successivi. Negli anni ’60 e ’70 una buona parte dei fumetti è a colori, mentre
è già in fase avanzata l’integrazione degli eroi “importati” dall’estero con
quelli “nostrani”. E’ il momento dei “Supereroi” come l’Uomo Ragno, Devil, i
Fantastici Quattro, ma anche di testate come Linus, Eureka, Diabolik e Alan Ford
che si affermano nel mercato fumettistico. Il “periodo moderno” (anni ’80 e ’90)
è contraddistinto da una miriade di case editrici che durano, non di rado, lo
spazio di un miserere. Su tutti, due fenomeni s’impongono all’attenzione dei
mass-media: i “Fumetti Giapponesi” e la “Bonelli”, leader oggi in Italia, che
con il suo capofila Tex – pubblicato ininterrottamente da più di cinquant’anni -
ha raggiunto vertici abbastanza alti di lettori.
“Il fumetto” – come sottolinea l’architetto Micciche'
in una delle piacevoli conversazioni intrattenute con la Redazione di Insieme –
“è una forma espressiva che, coniugando letteratura, lingua e disegno, dà più di
altre forme di comunicazione in quanto in grado di raggiungere qualsiasi uomo di
qualunque età e cultura, graduando solo l’intensità e la qualità del messaggio.
Esso nasce, muore, rinasce con sorprendente vitalità, seguendo mode e
aspirazioni, alla ricerca del dialogo con il pubblico”. Un dialogo che viene
garantito anche dalla tenacia e dal costante impegno profuso dalla moglie Lina.
Giuseppe Nativo
* Articolo pubblicato sul quindicinale "Insieme", n.441
del 1° marzo 2007, pag.5. |
Home Page
|
