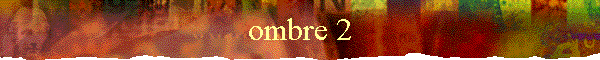|
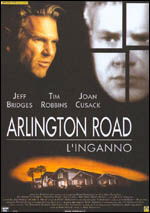
|
Arlington
Road
di
Mark Pellington
(U.S.A.
1999 117’)
di
alessandro de filippo
|
|







|
Dettaglio
dei piedi di un uomo che procede barcollando. L’uomo calpesta la linea
tratteggiata che delimita il centro della carreggiata. Gocce di sangue
bagnano l’asfalto. Altre gocce macchiano le scarpe. L’uomo in
controluce, forse è un bambino, avanza a fatica. Ha un braccio
insanguinato.
Arlington
Road funziona così: un racconto
per frammenti, per dettagli. Dettagli che tendono a nascondere, piuttosto
che mostrare la verità. L’immagine è sempre di per se stessa ambigua e
necessita di un contesto per acquisire un significato preciso, per
veicolare un messaggio. Per questo avvertiamo immediatamente la difficoltà
di lettura delle immagini di questo film: ci mancano i riferimenti per
comprendere i personaggi e le motivazioni che li muovono... molti elementi
restano inspiegabili, perché la struttura narrativa piana e lineare del
cinema classico è stata sostituita da una tecnica che tende a
rappresentare la visione, sia essa il ricordo (i continui rimandi in
flash-back alla vita e alle motivazioni della morte della moglie del
professore), oppure l’ostinazione, al limite dell’ossessione
paranoica, con cui il protagonista cerca di ricostruire dalle menzogne la
trama del complotto terrorista del proprio vicino di casa.
La
figura del “terrorista” è all’interno del sempre più consolidato e
canonizzato genere della spy-story thriller: c’è l’FBI miope, come al
solito, nella lettura analitica della realtà; c’è il cattivo, cinico e
un po’ viscido (interpretato da un grandissimo Tim Robbins), che studia
l’attentato supremo alla libertà democratica a stelle e strisce; c’è
la famiglia dell’eroe, sacrificata (la fidanzata) o sacrificabile (il
figlio) che funziona come stimolo, come spinta all’azione, al supremo
atto eroico ed inevitabilmente al sacrificio; infine c’è appunto
l’eroe (uno sbandato e credibilissimo Jeff Bridges, almeno negli ultimi
5 film sempre nel ruolo di alcolista), un uomo caparbio, circondato da
un’incomprensione generale, che lentamente si trasforma in indifferenza
e infine in fastidio da parte della cosiddetta società civile.
La
diffidenza nei confronti del proprio vicino di casa porta quindi l’eroe
al progressivo e inevitabile isolamento fino alla manifestazione terribile
di un mondo al contrario, che difende i malvagi attraverso la sicurezza
della privacy e della proprietà privata e che condanna i buoni che
decidono di non rispettare le regole, se queste sono un limite
all’attuazione del bene, inteso come salvezza globale. E credo che il
professore di storia contemporanea, un intellettuale, che lavora
all’università, che è abituato a ricercare la verità attraverso studi
e analisi razionali, sia appunto un personaggio topico all’interno del
panorama cinematografico classico americano e che “classicamente” sia
condannato a perdere, a perire, ad essere male interpretato. C’è sempre
stato il profeta inascoltato ad hollywood, dai film di argomento biblico,
al detective del noir, al commissario violento nei polizieschi degli anni
‘70, al comandante Sigourney Weaver della navetta della saga di Alien, a
Sara Connor di Terminator, agli umani delle invasioni aliene di Don Siegel
prima e Abel Ferrara poi... e sempre, l’eroe-profeta si è confuso con
il matto, con il paranoico, con l’ossesso. È interessante soprattutto
per questo la scelta in Arlington Road di raccontare il mondo dal punto di
vista del folle: immagini sconnesse, slegate; ancora frammenti di storia,
di realtà, di verità storiche non ricostruite e non teorizzate;
ricordi... il primissimo piano rende impossibile la comprensione, rende
fallace persino qualsiasi forma di riconoscimento... chi è il terrorista?
chi è l’eroe? chi è stato ferito e sanguina trascinandosi per la
strada? chi gioca con l’esplosivo?
alessandro
de filippo
adefi@tiscali.it
maggio
2005 |
|
l'autore:
Alessandro
De Filippo vive e lavora a Catania. Si occupa di critica cinematografica e
televisiva; tiene annualmente cicli di lezioni di «Tecnica
Cinematografica» e «Teoria Cinematografica» presso la Facoltà
di Lettere e Filosofia dell’Università
degli Studi di Catania; ha realizzato numerosi corsi-laboratorio di
educazione all’immagine, rassegne cinematografiche e un workshop sulle
costanti linguistiche del cinema hard-core, programmato in diversi
festival italiani e all’interno del Triple X
di Ljubljana e dell’InterFilm Festival Berlin. Da
settembre 2001 è docente di Lettere.
È
autore
di cortometraggi, documentari e installazioni video: Occhio nudo
(1994) Raus (1996) Birds as punctuation (1998) Joy
(1999); Lebeul me (2001).
Direttore
della fotografia e operatore di ripresa realizza nel 1998 la docufiction
RAI Rimedi contro l’amore,
vincitore del Nastro d’Argento come miglior mediometraggio; nel 1999 il
documentario RAI su Minimalia – una visione del XX secolo, mostra d’arte contemporanea a
cura di Achille Bonito Oliva, girato nel museo P.S.1
di New York; nel 2000 è ancora direttore della fotografia del
documentario RAI Lava Flow, sull’arte contemporanea catanese; sempre nel 2000 è
direttore della fotografia della fiction Strike
a light,
presentata al Festival di Cannes; per la televisione svizzera, cura la
fotografia del documentario What is love? sulla Zürich Street
Parade.
Nel
1996 entra a far parte del gruppo Cane CapoVolto; insieme agli
altri due membri, Enrico Aresu e Alessandro Aiello, compie una ricerca
radicale sui media dello Spettacolo; come membro del gruppo, è
rappresentante italiano all’Experimental
European Cinema Project, simposio organizzato a Tokyo dal
cineasta sperimentale e scrittore Yann Beuvais, per l’Istituto Franco
Giapponese.
Collabora
con il sito http://www.postcontemporanea.it/
.
Per
contattarlo: e-mail adefi@tiscali.it.
|
ombre 001:
Ombre, bianco contro nero
ombre 003:
Blade Runner, di Ridley Scott
ombre 004: Pane
e fiori, di Mohsen Makhmalbef
ombre 005: Bread
and Roses, di Ken Loach
ombre 006: Slam,
di Marc Levin
ombre 007: Do
the Right Thing, di Spike Lee
Home
Page
|