Latenze del cristianesimo: il fuoco sempre vivo del neoplatonismo
Latenze del cristianesimo: il fuoco sempre vivo del neoplatonismo
di Francesco Clemente
Nel contesto di inizio millennio segnato dall’incalzare della tecno-scienza, ove la legittimità del sapere è quasi del tutto fagocitata dalla sua potenziale applicabilità, mettere a tema la religione e la spiritualità può suonare come un esercizio culturale rivolto a veri e propri relitti della cultura, oltre che come un atto di miopia intellettuale volontaria per chi ha deciso di ignorare il fatto che questi argomenti trovino una definitiva risposta nelle sentenze del disvelamento razionalistico. Invece, spesso la storia ha dimostrato che in momenti di scientismo forte capiti di raccogliere esigenze profonde che vanno ben al di là di esso.
Questo succinto focus deve essere inteso non come un velleitario responso su questioni teoriche e storiografiche di incommensurabile portata, quanto un’offerta di riflessione per chi pensa di aver maturato un percorso di fede senza aver rinunciato alle esigenze della ragione, ma anche per chi ha avvertito l’urgenza di un percorso metafisico e spirituale fuori dai canoni della confessionalità. La curiosità si addensa su quel mare magnum composto dai rapporti fra ragione e fede, con un accenno inevitabile alla duplice e arcinota formula agostiniana dell’intelligo ut credam e credo ut intelligam. In questo ragguaglio concettuale è proprio il neoplatonismo – forte del suo armamentario epistemologico ereditato dal maestro Platone e accresciutosi nel corso dei secoli con i mille rivoli delle culture misteriche ed iniziatiche – a meritare uno sguardo fugace, per provare a suscitare qualche spunto ai fini di un confronto ampio fra le più diverse esperienze di ricerca interiore.
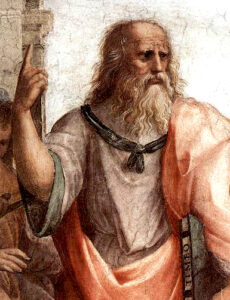
Neoplatonismo e Cristianesimo: un proteiforme rapporto fra filosofia, teologia e storia.
La relazione tra neoplatonismo e cristianesimo, in particolare nella sua formulazione ortodossa, si configura come uno dei temi più affascinanti della storia del pensiero tardo-antico e medievale. Si tratta di un’interazione complessa, da leggersi su più livelli: filosofico, teologico e storico. Il neoplatonismo sorge nel III secolo d.C. con Plotino, ma si sviluppa ulteriormente con Porfirio, Giamblico, Proclo, fino a influenzare profondamente la tarda Antichità e il Medioevo, derivando dal pensiero di Platone, ma con un’elaborazione sistematica e metafisica più sviluppata, in cui la determinazione dell’esistenza di un principio primo, l’Uno, al di sopra dell’essere e del pensiero implica la processione (πρόοδος, prodos) e la conversione (ἐπιστροφή, epistrophé): il mondo deriva dall’Uno e tende a ritornare a esso. In un quadro teorico segnato da una visione gerarchica della realtà – Uno → Intelletto (Νοῦς, Nous) → Anima del Mondo → mondo sensibile – trova poi posto una formulazione morale di intonazione ascetica, centrata sulla purificazione dell’anima per riunirsi al divino. D’altro canto, il cristianesimo ortodosso, (in senso dottrinale, cioè conforme alla retta fede, non solo in senso orientale) nasce in un mondo culturalmente ellenizzato e si confronta con la filosofia greca, nell’ardua impresa di affrontare e dirimere sfide cruciali: l’affermazione dell’unicità e della trascendenza di Dio, la sua personalità e la sua rivelazione storica (in Cristo), la difesa della creazione dal nulla (e non per emanazione), il riconoscimento del valore della materia, del corpo e della resurrezione, contro la svalutazione neoplatonica del sensibile, la conservazione di una teologia trinitaria e incarnazionista che non si confondesse con la struttura triadica del neoplatonismo.
Su questa piattaforma tematica – a volo d’uccello – si possono scorgere significativi punti di convergenza fra le due tradizioni. Sicché, al di là delle differenze teologiche, il pensiero cristiano avrebbe rinvenuto nel neoplatonismo categorie concettuali funzionali ad esprimere la propria fede, come ad esempio la trascendenza di Dio, terreno teoretico dove appunto l’idea neoplatonica di un Uno assolutamente trascendente è affine alla concezione cristiana di Dio come totalmente “altro”, infinito, inaccessibile.

A ciò, deve poi aggiungersi la gerarchia ontologica del neoplatonismo, che ha ispirato la cosmologia cristiana (Dionigi Areopagita, Gregorio di Nissa) fedele alla scansione fra Dio → angeli → uomo → animali → materia, nell’auspicio dell’adozione di un percorso interiore dove l’idea del ritorno dell’anima a Dio attraverso la purificazione è simile a quello promosso dalla spiritualità cristiana: l’ascesi, la preghiera, la contemplazione come vie verso l’unione con Dio. Ma – assodate queste consonanze – è indubbio che il cristianesimo uscito dalle elucubrazioni della patristica si sia impegnato nel corso dei secoli a differenziarsi dal retaggio neoplatonico, concentrandosi sullo scarto esistente non solo fra la prospettiva della creazione in antitesi a quella dell’emanazione, ma soprattutto arrovellandosi sull’incarnazione quale cifra inconfondibile del messaggio cristiano a confronto con l’incolmabile distanza fra il divino e la materia tenuta ferma dal neoplatonismo.
Alla luce di ciò, si staglia l’eccezionalità di Dionigi l’Aereopagita, ovvero lo Pseudo-Dionigi (V-VI secolo), fulgido esempio di fusione tra teologia cristiana e categorie neoplatoniche, non solo per l’utilizzo di un linguaggio ad alta densità simbolica e profondamente mutuato dal neoplatonismo (in particolare da Proclo), ma anche e soprattutto perché introduce la teologia apofatica nella tradizione cristiana, ovvero la prospettiva della teologia negativa, protesa a rapportarsi a Dio quale entità da definire per ciò che non è e non per caratteristiche evidenti ad esso attribuibili. Un pensiero – quello di Dionigi – che concepisce la struttura della gerarchia celeste in modo assai simile alle triadi neoplatoniche e che, tuttavia, in ultima analisi, adotta e afferma l’incarnazione, la Trinità e la creazione ex nihilo, esercitando un’enorme influenza non solo su tutta la teologia ortodossa ma anche di quella tipica della scolastica occidentale, come dimostra ad esempio la premura che ha avvertito S. Tommaso d’Aquino nel citarlo in direzione di un continuo confronto nel discorso su Dio, ovvero con il concepimento di una teologia negativa che culmina nel silenzio, oltre che nel superamento della distinzione tra oggetto e soggetto.
Un profondo misticismo che si propaga nella celebre triade di trattati intitolati Sulla teologia mistica, Sulla gerarchia celeste e Sulla gerarchia ecclesiastica, nei quali il sottofondo costante è la peculiare visione/conoscenza della dimensione dischiusa dal folto e criptico simbolismo dei riti liturgici.
Tuttavia – mettendo da parte quelle che si potrebbero etichettare come vere e proprie eccezioni – è sufficiente ricordare la natura variegata della galassia teoretica della patristica cristiana, soprattutto esponenti di rilievo della tradizione greca, di quella che poi dopo lo scisma del 1054 sarà annoverata nella manualistica e nella storiografia di vulgata come “patristica orientale” per differenziarla maggiormente dalla “patristica occidentale” sempre più progressivamente attratta nell’ orbita dell’impero carolingio. A proposito, ci si limita a citare Origene (influenzato da Plotino), Gregorio di Nissa (che adotta categorie neoplatoniche per descrivere l’itinerario dell’anima verso Dio), Basilio e Gregorio Nazianzeno (che indicano Platone come “alleato” nella ricerca della verità), fino a Massimo il Confessore (teso ad armonizzare elementi cristiani e neoplatonici, nella valorizzazione però della storicità e della centralità del Logos incarnato). Eppure, anche nell’occidente latinizzato il neoplatonismo è tornato a esprimersi in maniera poderosa nel Rinascimento, in una fase in cui il cattolicesimo romano non solo si stava ancora leccando le ferite provocate dalla cattività avignonese, ma si sarebbe dovuto faticosamente attrezzare per fronteggiare il dilagare della riforma luterana a partire dal 1517, predisponendo i lavori per il concilio di Trento in vista della controriforma.

Si potrebbero individuare almeno cinque motivazioni per spiegare la riemersione del neoplatonismo dal suolo carsico del cristianesimo:
- La riscoperta dei testi antichi: grazie alla caduta di Costantinopoli (1453), molti intellettuali bizantini emigrarono in Occidente portando con sé manoscritti greci, fra cui molte opere di Platone, Plotino, Proclo e altri neoplatonici trascurati nel Medioevo a favore di Aristotele;
- L’esigenza di un’alternativa ad Aristotele e quindi all’egemonia dell’aristotelismo tomista, per offrire una visione più spirituale, mistica e simbolica, più affine alla sensibilità rinascimentale e quindi utile per rifondare la filosofia su basi nuove, più adatte all’Umanesimo;
- L’affermazione della centralità dell’uomo e dell’anima nella cornice di una riscoperta della dignità dell’essere umano: il neoplatonismo, con la sua idea di anima immortale che tende al divino, si adattava perfettamente a questa visione;
- La convinzione diffusa della compatibilità con il Cristianesimo, nel solco teoretico che riteneva il neoplatonismo più facilmente conciliabile con la fede cristiana, rispetto all’aristotelismo grezzo e naturalistico: temi come l’Uno, la gerarchia degli esseri, l’ascesa dell’anima e la luce divina erano interpretabili in chiave cristiana;
- L’influenza della cultura magico-simbolica: il Rinascimento fu anche l’età dell’interesse per l’astrologia, l’alchimia, la magia naturale: il neoplatonismo forniva una cornice teorica e metafisica per questi saperi, per cui filosofi come Marsilio Ficino (1433-1499) e Giordano Bruno (1548-1600) integrarono platonismo, ermetismo, Cabala e altre dottrine esoteriche. Fattori – questi – che rendono chiaro il terreno su cui si sono espressi e formati anche pensatori del calibro di Giovanni Pico della Mirandola (1463-1494) e Niccolò Cusano (1401-1464) e che supportano l’idea che il neoplatonismo rinascimentale fu molto più di una moda intellettuale.

Esso, infatti, rispondeva a esigenze culturali, religiose e spirituali profonde. In un’epoca di rinnovata fiducia nell’uomo, di riscoperta della classicità e di tensione verso l’infinito, la filosofia neoplatonica fornì un ponte ideale tra mondo antico e visione cristiana del mondo, contribuendo alla nascita di una rinnovata concezione dell’uomo e della realtà. Infine, all’inizio del XX secolo si riscoprono in ambito ortodosso – inteso come cristianesimo orientale (soprattutto russo e greco) – i Padri della Chiesa e in particolare Gregorio Palamas, mentre l’esperienza umana e teologica di Pavel Florenskiy nella Russia dell’ateismo di stato comunista svetta in virtù di un poderoso tasso teoretico, suscitando nel corso dei decenni un interesse crescente nella cultura accademica occidentale, soprattutto dopo il crollo del muro di Berlino.
Rifrazioni di una tradizione filosofica
Ora, volgendo al termine di questo breve scritto, è doveroso precisare che il rapporto tra neoplatonismo e cristianesimo forse suggerisce qualcosa in più di un esempio tangibile di inculturazione riferito al pensiero cristiano. In ultima analisi, si intende proporre qualche considerazione ulteriore a quelle che – tradizionalmente – si limitano a constatare che la dottrina cristiana abbia difeso la propria originalità e identità teologica, trasformando categorie filosofiche preesistenti, per esprimere in modo più profondo e sistematico il mistero di Dio e della salvezza. Ed è consequenziale per chi scrive lanciare una provocazione centrata sulla constatazione che il cristianesimo – almeno così come si è andato configurandosi nel corso dei secoli in Occidente – una volta legittimatosi da un punto di vista dottrinale – non abbia più avvertito l’esigenza di tenere vivi quei temi e quelle istanze di pensiero che proprio il neoplatonismo con la sua robustezza ontologica e gnoseologica aveva dimostrato di delucidare e di organizzare, con l’esito finale di aver svilito una spinta di ricerca e di razionalità nutrita da quei fedeli che per ossequio alla loro intelligenza non hanno voluto rinunciare alle rivendicazioni di quest’ultima.
Quegli stessi fedeli che – fra l’altro – hanno avvertito l’esigenza di uno strumento supplementare al rischiaramento della fede (intelligo ut credam), che si sommasse all’esercizio dell’esegesi dei testi religiosi e che andasse ben al di là della ricezione di una tradizione stanca e stereotipata, spesso ridottasi al semplicismo della raffigurazione presepiale. Una forza teoretica e simbolica che sembra poi essersi sopita grazie all’incalzare in Occidente della tradizione dell’aristotelismo cristiano e che sembra poi aver subito il suo intorpidimento finale con il dilagare della secolarizzazione, quel fenomeno di lunga durata che si è accompagnato per un verso ad una quasi totale desertificazione metafisico-spirituale dell’Occidente cristiano sotto l’egida del cattolicesimo (nella migliore delle ipotesi ridotto a blanda agenzia etico-morale), per un altro verso all’esplosione di esiziali e ingestibili fanatismi germinati nell’universo orientale dell’Ortodossia cristiana, spesso con ingiustificabili (anche sul piano dottrinale) faide religiose.

Dunque – alla luce dell’esercizio dell’argomentazione filosofica anche su un piano ontologico tout court – la riscoperta della tradizione neoplatonica apre un terreno di confronto dove è la ragione con i suoi mezzi ad accomunare quanti intendono riscoprire non solo la libertà affrancatrice dall’imperante scientismo algoritmico di inizio millennio, ma anche quell’humus di categorie e concetti che sono serviti ad affacciarsi alla fede (in questo caso cristiana in senso lato), superando così il rischio di una “seconda pelle” ereditata nei secoli e verso la quale non si è tentata alcuna riappropriazione intima e personale. Il punto è – in via definitiva – il valore intrinseco di una ricerca che già in Platone suggeriva chiaramente uno sforzo interiore per scalare i gradini della verità, un impegno teso a conquistarsi la visione di quei principi formali che sono le idee e che si completa poi con la virtuosa comprensione della loro articolazione logica, quella “seconda navigazione” così come risulta garantita dal procedimento diairetico. Tale “guadagno del divino”, ovvero l’accesso privilegiato all’immutabile, il retaggio platonico – quindi neoplatonico – gratifica la ragione nelle sue richieste di esplorazione della realtà, fino a raggiungere il punto in cui essa è costretta ad arrestarsi a ciò che non è più deformabile dalla soggettività.
In questa ricerca tesa a riannodare le fila della tradizione e della storia anche lo stesso tema della caduta dell’uomo – che apre il libro del Genesi del Vecchio Testamento e che di fatto costituisce il punto ineludibile della tradizione ebraico-cristiana – assume un carattere decisamente diverso da quello della semplice violazione della prescrizione divina e delle conseguenze che ne sarebbero poi scaturite. Concedendo qualcosa all’elucubrazione libera del pensiero – infatti – lo si potrebbe leggere come una condizione di “caduta ontologica”, una sorta di “alienazione metafisica”, quella lontananza dall’Essere, da cui scaturirebbe una condizione di “esilio strutturale”, la radice metafisica di una difettività costitutiva dell’uomo, attraverso la quale leggere e interpretare anche e soprattutto l’ombra che da sempre lo accompagna.
Francesco Clemente
29 ottobre 2025
Immagine sotto il titolo: Marsilio Ficino, Giovanni Pico della Mirandola e Angelo Ambrogini, detto Poliziano, affresco del 1485-1486) di Cosimo Rosselli (dettaglio). Chiesa di Sant’Ambrogio (Firenze), Cappella del Miracolo dell’Eucarestia.
Nota 1.: Uno spunto che meriterebbe un approfondimento specifico è il confronto con la prospettiva di Damascio, filosofo bizantino neoplatonico (Damasco, 450 circa – Alessandria d’Egitto, dopo il 533), vissuto tra la seconda metà del V secolo e la prima metà del VI secolo. Distanziandosi dal pensiero del suo maestro Proclo, Damascio riprende e sviluppa la precedente posizione di Giamblico, ponendo anteriormente all’Uno un altro principio totalmente ineffabile e trascendente, del quale non può dirsi neppure se sia conoscibile o meno: l’assoluto silenzio dell’ineffabile abisso della divinità. Questo aspetto lo colloca all’interno del misticismo intellettuale/apofatico (l’esperienza dell’ineffabile attraverso la vita contemplativa interiore) consonante con il pensiero indiano noto come Advaita Vedānta.




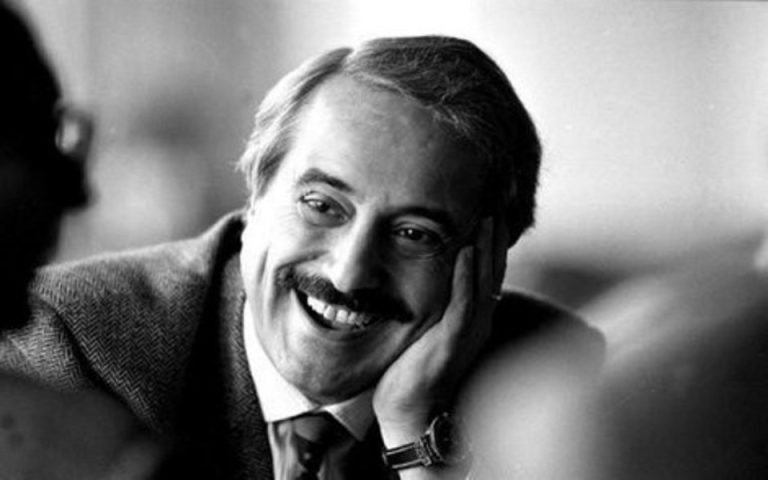


Un brano di elevata cultura filosofica, intriso di una palpitante spiritualità a-dogmatica, è quello del prof. Francesco Clemente. La sua bravura espositiva di ardui concetti ha una valenza di chiarezza cristallina. Se il cristianesimo ha riscoperto tardivamente la preziosità della scala ascensionale del neoplatonismo, ciò non è avvenuto da parte degli studiosi di magia fino al rinascimento e che in Guènon ha trovato una elaborazione sistematica, cui si deve il merito di averla segnalata con i suoi libri alle scuole iniziatiche: dall’immanifesto al manifesto, dal duale all’unità in un’ascesa purificatrice dell’anima che si spoglia dei suoi metalli. E ci sarebbero da evidenziare i punti di contatto tra il neoplatonismo e l’agostinismo per comprendere che ogni pensiero è manifestazione del “sacro” e va accolto con dignitoso rispetto dopo che c’è stata la caduta dei “gigli”. Grazie prof. Francesco Clemente!
È il processo della manifestazione universale:
tutto ha origine dall’unità e all’unità ritorna;
nell’intervallo si produce la dualità, divisione
o differenziazione da cui risulta la fase dell’esistenza
manifesta. L’ordine appare solo se ci si eleva al
di sopra della molteplicità, si smette di considerare
ogni cosa isolatamente e “distintamente”, per
contemplare tutte le cose nell’unità. La “grande
guerra santa” è la lotta dell’uomo contro i nemici
che egli ha in se stesso, vale a dire contro tutti gli
elementi che, in lui, si oppongono all’ordine e
all’unità.
Renè Guenon